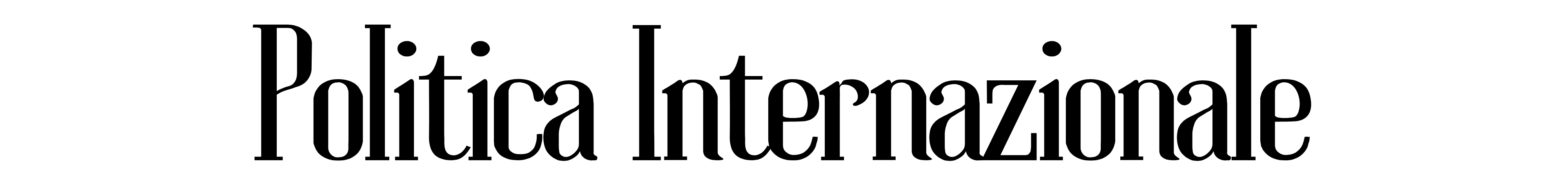Negli anni successivi alla devastante Seconda guerra mondiale, l’Europa si trovava di fronte a un compito urgente: ricostruire un continente diviso, segnato da conflitti e divisioni politiche, e garantire un futuro di pace, stabilità e prosperità. In questo contesto, nasceva l’idea di creare un’area di cooperazione tra i paesi europei, focalizzata sulla collaborazione economica come primo passo verso l’integrazione politica più profonda. Questa ambizione si concretizzò, nel 1957, con la firma del Trattato di Roma, che istituiva la Comunità Economica Europea (CEE).
Le origini e gli obiettivi della CEE
La CEE fu ideata dai sei paesi fondatori: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania Ovest e Italia. L’obiettivo principale era eliminare le barriere doganali e le restrizioni commerciali, creando un mercato unico in cui beni, servizi, capitali e persone potessero circolare liberamente. La visione dei legislatori di allora era chiara: favorire la crescita economica, aumentare la competitività dell’Europa e rafforzare i legami tra gli stati membri, scoraggiando i ritorni ai conflitti nazionali e promuovendo un senso di unità tra i popoli europei.
Il trattato prevedeva anche la creazione di istituzioni comuni, come la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, che avrebbero gestito e regolamentato questa nuova comunità. La scelta di puntare su un’unione economica più stretta rappresentava un passo cruciale, poiché si riconosceva che la cooperazione economica avrebbe potuto svilupparsi in un’area più ampia di integrazione politica.
L’espansione e lo sviluppo della CEE
Nei decenni successivi, la CEE si espanse, con l’adesione di nuovi paesi e la creazione di politiche comuni in diversi settori strategici. La crescita economica degli anni ’60 e ‘70 contribuì a rafforzare il senso di appartenenza all’Europa. La liberalizzazione del commercio interno e la riforma delle politiche agricole e dei trasporti furono alcuni dei principali tramiti di questa evoluzione.
Leggi anche: La Crisi attuale dell’Europa a livello geopolitico
Parallelamente, le istituzioni europee si rafforzarono, diventando sempre più una vera e propria governance sovranazionale. La cooperazione si fece più strutturata e complessa, aprendosi anche a iniziative di tutela ambientale e di sviluppo regionale. La CEE si presentava come un’unione di Stati che, pur mantenendo la propria sovranità, decidevano di collaborare in modo più stretto per ottenere benefici condivisi.
Il passo decisivo: da CEE a Unione Europea
Il vero cambio di passo avvenne nel 1992 con il Trattato di Maastricht, che segnò la trasformazione della CEE nell’attuale Unione Europea. Oltre a formalizzare questa unione politico-economica, il trattato introdusse nuove politiche come quella di politica estera e di sicurezza comune (PESC), dando un ruolo più deciso all’unità tra gli stati membri anche nei rapporti con il resto del mondo.
Questo processo di integrazione si è rafforzato negli anni successivi, con la creazione della moneta unica, l’euro, e l’adozione di strumenti comuni per affrontare le crisi economiche e sociali. La figura del Parlamento Europeo, attraverso il suo ruolo di legislatura, è cresciuta come rappresentate diretto dei cittadini europei.
Oggi, l’Unione Europea conta 27 paesi membri e rappresenta una delle più grandi economie al mondo, impegnata a mantenere i valori della pace, della libertà e dello sviluppo sostenibile. L’evoluzione della CEE, da semplice blocco economico a grande progetto di integrazione politica, testimonia la volontà degli Stati europei di collaborare per un futuro comune. Il percorso della Comunità Economica Europea resta uno dei capitoli più significativi della storia europea del XX secolo, un esempio di come la cooperazione possa portare a un’Europa più unita e forte.