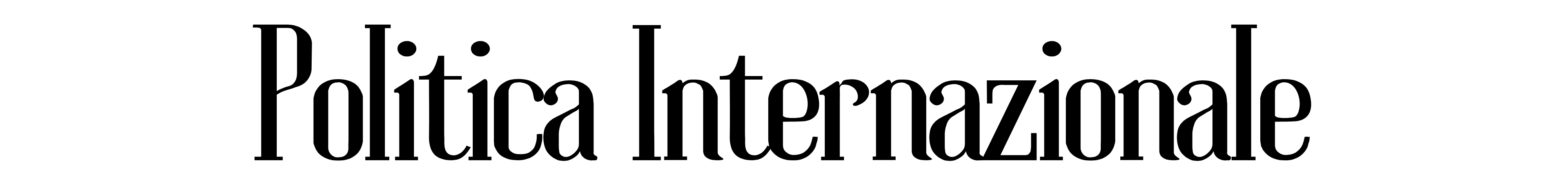La relazione tra Iran e Occidente, in particolare Stati Uniti e Regno Unito, è una delle più complesse e radicate nella geopolitica contemporanea. Tra conflitti, invasioni, rivoluzioni e interessi energetici, questa lunga storia di inimicizie e alleanze inconsistenti ha plasmato il destino di un Paese ricco di risorse e simboli di potere. Questo articolo analizza le tappe fondamentali di questa intricata relazione, evidenziando come eventi storici e strategici abbiano condotto alla situazione attuale.
Origini coloniali e la scoperta del petrolio
All’inizio del XX secolo, con l’estrazione del petrolio e la crescente domanda energetica mondiale, l’Iran divenne il bersaglio principale degli interessi coloniali anglo-russi. La regione, ricca di riserve di greggio, venne progressivamente sotto l’influenza delle due potenze, che si sfidavano nel cosiddetto “Grande gioco”. Durante la Prima Guerra Mondiale, gli inglesi occuparono il Paese, ma evitarono di trasformarlo in un protettorato diretto, preferendo mantenere il controllo delle risorse petrolifere tramite un’intricata rete di concessioni e accordi.
Il controllo britannico si consolidò con le concessioni ottenute dalle compagnie petrolifere, come l’Anglo-Persian Oil Company (poi British Petroleum), che esercitava un dominio quasi totale sulle riserve iraniane. Parallelamente, la sfida tra Londra e Mosca coinvolse l’Iran nel contesto della spartizione e del dominio coloniale, lasciando profonde ferite nella memoria collettiva del Paese.
La nascita di Reżā Pahlavī e le prime riforme
Nel 1921, Reżā Pahlavī salì al potere e nel 1925 si proclamò Scià di Persia. Durante il suo regno, Reza Shah Pahlavi intraprese una serie di riforme volte a modernizzare l’Iran: costruzione di infrastrutture, università, e un tentativo di ridurre l’influenza del clero sciita. Tuttavia, si scontrò con le potenze coloniali e con le pressioni dell’Occidente, preoccupate che il nazionalismo iraniano potesse minacciare i loro interessi petroliferi e geopolitici.
In particolare, Reżā Pahlavī cercò di rafforzare l’indipendenza del Paese stringendo rapporti con la Germania nazista, provocando la reazione dei britannici e dei sovietici, che nel 1941 invasero l’Iran e imposero un suo successore, creando le premesse di un rapporto spesso complicato e conflittuale con gli attori occidentali.
La sfida energetica e lo scontro tra superpotenze
Dopo la Seconda guerra mondiale, l’Iran divenne teatro di ulteriori tensioni tra le superpotenze, con gli USA e il Regno Unito intenta a mantenere il controllo delle sue risorse energetiche. La nazionalizzazione del petrolio, voluta dal primo ministro Mohammad Mossadeq nel 1951, rappresentò un punto di svolta: il popolo iraniano si schierò compatto contro le multinazionali occidentali, portando alla nazionalizzazione dei giacimenti.
La reazione occidentale non tardò: nel 1953, con l’Operazione Ajax, la CIA e il MI6 organizzavano un colpo di Stato che rovesciò Mossadeq e ristabilì lo Scià al potere. Questo episodio, tuttora doloroso e ricordato in Iran come un atto di ingerenza coloniale, segnò un punto di non ritorno nella relazione tra Iran e Occidente.
La rivoluzione del 1979 e il nemico pubblico numero uno
Nel 1979, il popolo iraniano scacciò lo Scià, ora visto come uno strumento degli interessi occidentali, e portò al potere l’ayatollah Khomeini. La rivoluzione islamica impose un nuovo ordine teocratico e nazionalista, e segnò l’inizio di un’importante rottura con gli Stati Uniti, culminata nel famoso sequestro degli ostaggi all’ambasciata americana di Teheran.
Da quel momento, Iran e Stati Uniti diventarono nemici pubblici, con rivolte popolari, sanzioni, e crescente tensione militare. Gli Stati Uniti, dalla loro parte, mantennero un interesse strategico nella regione, sostenendo Saddam Hussein nella guerra Iran-Iraq (1980-1988) e intervenendo in vari conflitti per tutelare i propri interessi nel Golfo persico e nel Medio Oriente. La guerra Iran-Iraq, che durò quasi un decennio, rappresentò uno dei capitoli più sanguinosi di questa lunga rivalità, con milioni di morti da entrambe le parti e il coinvolgimento di potenze straniere che favorirono il regime di Saddam Hussein.
La situazione odierna: tra tensioni e ambizioni geopolitiche
Dopo decenni di conflitti e diplomazia incerta, le tensioni tra Iran e Occidente continuano a essere al centro della geopolitica globale. Le questioni nucleari, il programma missilistico e il sostegno a gruppi armati nella regione alimentano il sospetto reciproco e la proliferazione di sanzioni e negoziati. La presenza di potenze mondiali come gli Stati Uniti, la Russia e la Cina rende più complesso il quadro, mentre Iran cerca di affermare la propria autonomia e rivalutare il ruolo di protagonista nel Medio Oriente.
Una storia di rivalità che plasma il presente
La lunga storia di ingerenze coloniali, rivoluzioni, guerre e alleanze instabili ha lasciato un’impronta indelebile sulla percezione reciproca tra Iran e Occidente. La memoria delle ingiustizie passate, unita alle attuali sfide geopolitiche, rende difficile un riavvicinamento duraturo. Comprendere questa storia è fondamentale per interpretare i movimenti politici e diplomatici attuali, ed è un passo importante per esplorare future possibilità di dialogo e stabilità in una regione così strategica e complessa.