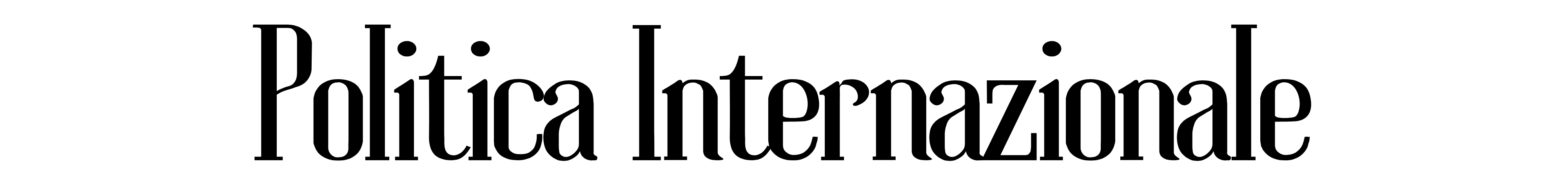Secondo il sociologo statunitense Robert Merton,la nostra vita quotidiana si basa su credenze, aspettative, definizioni, supposizioni che per il solo fatto di essere state pronunciate possono trasformarsi in effetti reali, andando a sviluppare proprio la profezia che si autoavvera. Merton si era ispirato al teorema di un altro sociologo, William Thomas, il quale affermava che «se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze». Questo perché le convinzioni che un individuo ha di sé influenzano le sue azioni verso gli altri, le quali hanno un impatto sulle convinzioni che altri hanno su di lui, le quali determinano le azioni altrui verso l’individuo, il quale vede rinforzare le proprie convinzioni iniziali su sé stesso. In poche parole, un circolo che si auto-alimenta.
Ma come si può applicare tale concetto di profezia che si autoavvera, puramente sociologico, alla politica estera?
Poiché i leader politici e i rispettivi establishment sono, prima di tutto esseri umani (con le proprie credenze e percezioni), la profezia che si autoavvera è perfettamente applicabile.
In particolare, ci possono essere diversi casi in cui essa si verifica:
- Quando si lega, nelle relazioni internazionali, al cosiddetto “dilemma della sicurezza”. Quest’ultimo avviene quando uno stato, percependo una minaccia (che può essere reale o presunta) aumenta le proprie capacità militari. Questa azione, però, può essere interpretata dagli altri stati come una minaccia, portandoli a fare lo stesso, creando un ciclo di armamenti che può portare a uno stato di maggiore tensione e rischio di conflitto. In pratica la costante ricerca di sicurezza porta esattamente al contrario, e cioè ad una maggiore insicurezza e tensione (o, addirittura, all’escalation). Il tutto avviene proprio a causa della percezione, che può essere anche sbagliata. Il risultato finale è che due stati diventano effettivamente una minaccia l’uno per l’altro, anche se all’inizio nessuno dei due lo era.
- Aspettative negative su un alleato o partner. Se un Paese ritiene che un alleato non sia affidabile o stia per cambiare schieramento, può iniziare a limitare la cooperazione con questo o a prendere decisioni unilaterali. Questo atteggiamento può minare il rapporto e spingere davvero l’alleato a distaccarsi.
- Etichettare un attore come “Stato canaglia”. Attribuire ad un Paese il ruolo di “nemico”, “aggressore” o “stato canaglia” può giustificare sanzioni, isolamento e minacce. Questo può radicalizzare l’attore etichettato, portandolo a comportamenti effettivamente aggressivi, in linea con la percezione iniziale.
Evitare la Profezia Che Si Autoavvera, soprattutto in politica estera, è una sfida cruciale, poiché le percezioni errate, i sospetti reciproci o le azioni preventive possono innescare proprio gli eventi che si cercava di evitare. Per farlo, è necessario intervenire sia sul piano della percezione che su quello delle azioni concrete. Difatti, ci sono diverse azioni che possono essere intraprese:
- In primis, non interpretare automaticamente le azioni altrui in chiave aggressiva, ma effettuare un’analisi più ampia del contesto: un’apparente minaccia potrebbe essere una risposta difensiva.
- Attuare le cosiddette “Confidence-building measures” (CBMs), ovvero delle esercitazioni militari trasparenti, ispezioni reciproche e trattati di non aggressione. Queste misure vengono intraprese proprio per ridurre la diffidenza (con una possibile escalation) e aumentare la confidenza.
- Avere una comunicazione strategica e trasparente. L’obiettivo è anche evitare le ambiguità: infatti, anche i messaggi poco chiari possono essere interpretati come minacce. Meglio una chiarezza nelle intenzioni e anche mantenere i canali diplomatici attivi.
- Promuovere una narrativa politica interna possibilmente matura, basata su fatti. Per questo motivo, occorre affidarsi a una pluralità di fonti, in modo da avere una visione più ampia e oggettiva,
- Imparare dalla storia: studiare i casi passati di escalation involontaria può aiutare a riconoscere segnali simili.