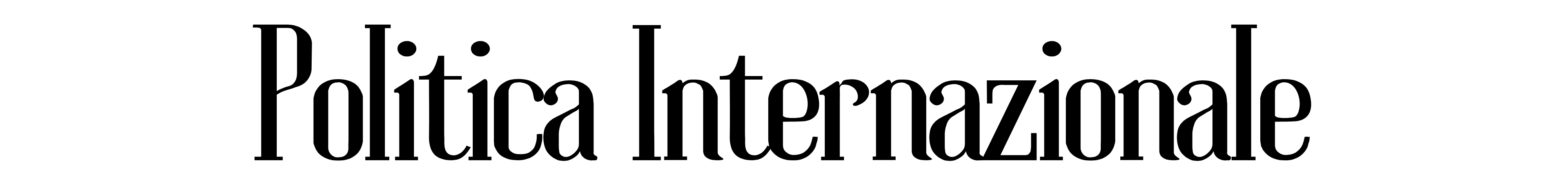Come ben noto, l’Italia è la seconda potenza manifatturiera d’Europa e l’ottava del mondo, con ben 1160 miliardi di euro di fatturato e con una crescita dell’export del 2,6% nel 2024, superando il Giappone nei primi sei mesi dello stesso anno in termini di export complessivo, pari a 316 miliardi di euro, e posizionatasi quarta dietro a giganti come USA, Cina e Germania.
Tuttavia, il Bel Paese è da sempre caratterizzato da una carenza di materie prime necessarie al mantenimento del proprio apparato produttivo, in particolare le cosiddette materie prime strategiche.
Nel 2023 la Commissione Europea ha emanato il Critical Raw Materials Act, un provvedimento strategico avente come obbiettivo la riduzione della dipendenza dalle importazioni extra UE di tali materie prime (in primis dalla Cina) entro il 2030, individuandone 34 elementi principali.
Nonostante il nostro paese non abbia ancora aggiornato la propria mappa mineraria sin dal lontano 1973 e l’attività estrattiva oggi sia sostanzialmente limitata alle sole rocce calcaree e al marmo, tra questi 34 elementi, ad oggi, l’Italia potrebbe estrarne sul proprio territorio appena la metà. Non tutti comunque presenti in giacimenti sufficienti per un’autonomia industriale ed il cui sfruttamento è ancora in corso di valutazione da parte delle autorità competenti.
Dei 16 elementi presenti in Italia occorre citare in primis il titanio: nel sito di Piampaludo, in Liguria, è stato rinvenuto uno dei principali giacimenti di titanio al mondo, con un potenziale estrattivo di almeno 9 milioni di tonnellate. Esso, ivi presente sotto forma di rutilo, ovvero un biossido di titanio, è in gran parte utilizzato per la produzione di pigmenti per vernici, plastica, carta e cosmetici. Inoltre, il titanio metallico è molto impiegato in leghe ad alte prestazioni per l’industria aerospaziale e biomedica.
Il valore di tale giacimento è stato stimato attorno agli 80 miliardi di euro nel 2012, in base al prezzo di mercato del titanio allora corrente, ma una volta raffinato e trasformato in prodotti finiti, raggiungerebbe un valore aggiunto fino a dieci volte superiore, senza contare le royalties di sfruttamento da destinare alla Regione Liguria, che beneficerebbe di circa 500 milioni di euro l’anno.
Tuttavia, il giacimento è situato all’interno del Parco Naturale del Beigua, dal 2005 ammesso dall’Unesco come Geoparco di valenza internazionale, oltre ad essere una delle zone più ricche di biodiversità della Liguria e dunque impossibile da sfruttare senza violare le normative ambientali e di protezione del patrimonio paesaggistico e naturalistico del paese, senza contare il danno potenziale percepito dalla comunità locale, la quale da molti anni beneficia dell’indotto economico derivante dal turismo legato al parco naturale.
Occorre poi considerare che, nonostante il titanio di per sé non comporti un particolare rischio ambientale, potrebbe però essere associato durante l’estrazione a metalli potenzialmente tossici come cobalto, cromo, zinco e nichel, oltre che alle eclogiti, rocce contenenti amianto, di cui il sito è piuttosto ricco.
Leggi anche: Le Terre Rare: Risorsa Strategica tra Innovazione e Sfide Ambientali
Oltre al titanio, un’altra materia prima strategica estraibile in Italia e presente in quantità consistenti è il litio: elemento cruciale per la costruzione di batterie e dunque essenziale per la transizione energetica in atto, è presente in discrete quantità lungo l’arco appenninico dal Piemonte all’Abruzzo, ma anche in Toscana, Lazio e Campania, disciolto in fluidi caldi a profondità variabili tra 500 e 2.500 metri. Questi fluidi, con concentrazioni di litio fino a 480 mg/l, sono tra le più alte al mondo per questa di risorsa.
Inoltre, l’eventuale estrazione del litio cosiddetto “geotermico” comporterebbe un impatto ambientale di gran lunga più sostenibile rispetto ai metodi tradizionali di estrazione di questo elemento, in quanto portato in superficie direttamente dai suddetti fluidi (utilizzabili parallelamente anche per produrre energia elettrica) e dai quali si può separare e stoccare con procedure semplici e veloci.
Dato da non sottovalutare se si considera l’elevato tasso di inquinamento circostante registrato nei pressi delle miniere di litio tradizionali, motivo che ha scatenato di recente diversi moti di protesta in Portogallo e Serbia, dove la cittadinanza locale si è opposta fermamente all’apertura di nuove miniere di litio, preoccupata dall’avvelenamento di falde acquifere e terre coltivate.
Ad ogni modo, se si considera la probabilità di estrarre in Italia non più di 5000 tonnellate di litio all’anno, non si arriverebbe comunque né a soddisfare il fabbisogno italiano né tantomeno quello europeo. Ma il punto non è solo l’assolvimento del proprio fabbisogno nazionale, quanto anche la differenziazione della catena di approvvigionamento.
Un tema fondamentale se si considera che la maggior parte dei minerali strategici proviene da paesi remoti e spesso soggetti a ciò che viene definito “rischio geopolitico”. Oltre alla possibile interruzione dell’export per problemi infrastrutturali e logistici, come guerre o disastri naturali, la catena di fornitura potrebbe essere compromessa anche da scelte politiche, dettate dalla volontà di ricatto dei paesi di origine nei confronti dei paesi destinatari.
Basti pensare che la Cina, impegnata ormai in un continuo confronto/scontro con gli USA, principale alleato dell’Italia e dei paesi europei, controlla circa il 60–70% della produzione globale e oltre il 90% della raffinazione delle terre rare al mondo, essenziali per l’industria delle alte tecnologie. Russia e Ucraina, invece, erano produttrici del 17% dell’import di titanio dell’UE fino a poco prima della guerra del 2022. Soltanto Kiev, inoltre, forniva il 50% del neon al mondo, necessario per l’alimentazione dei laser per la fabbricazione dei microchip.
Per questo motivo, il governo italiano ha dato avvio alla riapertura delle 76 miniere inattive sul proprio territorio (chiuse tra gli anni ’80 e ’90 e di cui in ben 22 di esse l’Ispra ritiene esservi presenti materie prime strategiche) con il decreto 84/2024, regolante l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche e strategiche presenti nelle poche riserve nazionali, il quale dovrebbe rendere più agevoli le procedure autorizzative, riducendone gli iter a 18 mesi.
Tra le miniere individuate, figura la miniera sarda di Silius, contenente oltre 3 milioni di tonnellate di fluorite, minerale strategico usato nell’industria dell’acciaio, dell’alluminio, del vetro, dell’elettronica e della refrigerazione, ma anche come complementare per la realizzazione delle batterie agli ioni di litio. Dopo 11 anni di iter burocratico è arrivato il via per poterla riaprire.
La concessione è stata ottenuta dalla Mineraria Gerrei, grazie anche a un finanziamento di Aruba, leader in Italia per i servizi cloud. Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro ed è previsto inoltre l’impiego di un centinaio di addetti. La partenza delle estrazioni dovrebbe avvenire entro fine 2025, con l’obiettivo di recuperare almeno 70 mila tonnellate l’anno di fluorite, oltre a 6800 tonnellate di galena.
Inoltre, il ministero dell’economia ha sbloccato il decreto attuativo del Fondo nazionale per il Made in Italy, che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro per favorire gli investimenti nel settore delle materie prime critiche: 700 milioni nel 2025, 300 milioni nel 2026 che, oltre a riattivare le miniere oggi ferme, verrebbero utilizzati per creare una filiera di lavorazione e riciclo delle materie prime importate.
Un elemento chiave, infatti, per l’autosufficienza di un paese così dipendente dalle importazioni delle materie prime strategiche, sta proprio nella capacità di riciclo e riutilizzo di tali materie.
Tra essi, le più facili da riciclare sono quelle appartenenti ai metalli ferrosi, come rame, alluminio (l’Italia è uno dei paesi leader al mondo nel riciclo di alluminio), zinco e piombo.
Quelle per cui le capacità di riciclo non sono al momento così immediate, ma in corso di sviluppo, invece, riguardano principalmente i materiali derivanti dalle batterie, come litio, cobalto, nickel e manganese, per il cui recupero in Italia esistono dei progetti promossi da alcune società come Enel X e COBAT.
Enel X ha avviato una collaborazione con MIDAC per sviluppare il primo grande impianto di riciclo delle batterie al litio in Italia, finanziato nell’ambito del programma europeo IPCEI (Important Project of Common European Interest), con l’obiettivo di trattare almeno 10.000 tonnellate di batterie all’anno.
Haiki COBAT, una delle quattro divisioni dell’italiana Haiki+, leader nel riciclo di materiali industriali, invece, attraverso la sua piattaforma EcoFactory ha sviluppato un impianto in Abruzzo per il recupero di materiali da batterie al litio. Questo impianto utilizza un processo brevettato che combina fasi meccaniche e idrometallurgiche per estrarre litio, manganese e cobalto da batterie esauste, provenienti sia da veicoli elettrici che da Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Tra le materie prime strategiche difficilmente riciclabili, infine, vi sono le terre rare ed altri materiali come germanio, indio e gallio, utilizzati nell’elettronica e per cui le tecniche di riciclo sono ancora economicamente insostenibili. Per alcune terre rare, come il neodimio e il disprosio ad esempio, sebbene vi sia già la tecnologia che ne consentirebbe il riciclo, essa tuttavia non ha ancora una declinazione industriale in Italia.
Pertanto, al fine di tutelare la propria industria manifatturiera, L’Italia dovrebbe muoversi in più direzioni: promuovere il riavvio delle attività minerarie (per quanto consentito dalle norme di tutela ambientale e del paesaggio, oltre che dal rispetto dell’equilibrio delle comunità locali); diversificare i propri approvvigionamenti, privilegiando le importazioni dai paesi alleati; investire sulle capacità di riciclo di tali materiali, con la possibilità nel lungo termine di sviluppare una solida autosufficienza strategica e tecnologica.